Søren Aabye Kierkegaard: tratti biografici
a cura di Nadia Tomasi
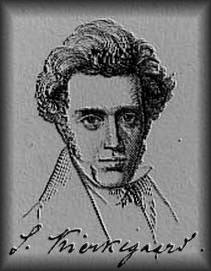 "Come mai può
venire in mente a qualcuno di fare l'elogio di quest'esistenza dove non c'è
che l'alternativa: o
di sopprimere in modo abominevole (crimine peggiore di un aborto) ogni aspirazione
ideale in grande stile e ogni possibilità d'idealità vera,
in ogni modo dimezzarla in maniera rivoltante… per poi gonfiarsi e rimpinzarsi
nella sconcia obesità degli onori e della stima mondani, –
oppure , qualora si voglia l'ideale, ci si deve
preparare a essere, eo ipso
, martiri.
"Come mai può
venire in mente a qualcuno di fare l'elogio di quest'esistenza dove non c'è
che l'alternativa: o
di sopprimere in modo abominevole (crimine peggiore di un aborto) ogni aspirazione
ideale in grande stile e ogni possibilità d'idealità vera,
in ogni modo dimezzarla in maniera rivoltante… per poi gonfiarsi e rimpinzarsi
nella sconcia obesità degli onori e della stima mondani, –
oppure , qualora si voglia l'ideale, ci si deve
preparare a essere, eo ipso
, martiri.
Il Cristianesimo è l'unica spiegazione
consistente dell'esistenza (†). L'esistenza terrestre è sofferenza;
ogni uomo ha la sua dose e le sue parole in punto di morte perciò
saranno: «Sia lodato Iddio che anche questo ora è passato!».
L'esistenza terrestre è tempo di prova,
è l'esame. Tutte queste chiacchiere di voler strafare, sono invenzioni
dei pastori per spillar denaro: è un genere di serietà che
abolisce Iddio […]."
[1] .
Agli scritti Kierkegaard affida la testimonianza
del significato dell'umana esistenza nella sua inequivocabile alternativa
e nell'unica spiegazione pregnante, lasciando intravedere la sua prospettiva
sull'ordine stabilito, la mondanità e, in filigrana, la sua stessa
vita. Parca di eventi esteriori quanto ricca di ripercussioni interiori,
essa, infatti, lo conduce attraverso una fanciullezza austera e una giovinezza
burrascosa e dissipata a stringere più intimamente il suo rapporto
al cristianesimo
[2] tanto da renderlo un penitente
[3] , spia della cristianità
[4] . I primi Diari
kierkegaardiani [5] dal 1834 al 1839 percorrono una linea di ricerca
del punto di Archimede dell'anima in balia dei flutti della vita "…
da cui poi mi son fatto l'idea dell'amore paterno di Dio, la sola cosa incrollabile
della vita, il vero punto di Archimede." [6] dove l'unica posta in gioco è il cristianesimo
che egli si consacrerà a chiarire spinto da un'esigenza personale
e dalla consapevolezza che era ciò di cui il tempo aveva bisogno.
Dal fumo romantico e idealista in cui fu avvolto
nei primi tempi, il suo sguardo si assottiglia, volgendosi decisamente verso
l'essenziale. Cadono così molti aspetti esteriori della sua dialettica,
ma si intensifica in compenso la dialettica interiore intorno al supremo
Aut-Aut: il finito e l'infinito, il temporale e l'eterno.
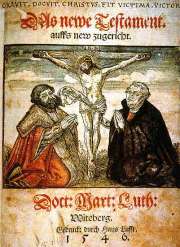 Saldamente ancorato al messaggio del Nuovo Testamento come all'unica cura radicale, Kierkegaard contesterà allora alla cristianità
stabilita gli inganni delle sue false prospettive di benessere terreno che
l'hanno riconciliata con il mondo.
Saldamente ancorato al messaggio del Nuovo Testamento come all'unica cura radicale, Kierkegaard contesterà allora alla cristianità
stabilita gli inganni delle sue false prospettive di benessere terreno che
l'hanno riconciliata con il mondo.
La biografia del filosofo danese rifluisce e
s'immedesima quasi con il suo pensiero, ma nel modo più impensato
e strano: la tenue trama dei fatti singoli si articola progressivamente nella
logica dei principi che formano la sua evoluzione spirituale.
Søren Aabye Kierkegaard nacque a Copenaghen il 5 maggio 1813 "… in quello sciagurato anno finanziario che tante banconote ha messe in circolazione. E la mia esistenza potrebbe benissimo paragonarsi a una di esse. …"
[7] .
 Il padre esercitò sulla vita morale e
spirituale di Søren, ultimo di sette figli, un'azione potente e durevole.
Kierkegaard nel
Il padre esercitò sulla vita morale e
spirituale di Søren, ultimo di sette figli, un'azione potente e durevole.
Kierkegaard nel
Diario
e nelle sue opere in genere ricorda di continuo la figura tormentata di
questo vegliardo, in cui il fervore ardente ed arido del pietismo moravo
si associava ad una misteriosa malinconia. Le discussioni religiose sottili
sulle quali amava intrattenersi introdussero precocemente Kierkegaard nel
campo della teologia e dell'etica e lo iniziarono ai metodi della dialettica,
così come lo studio appassionato della grammatica greca e latina lo
iniziarono all'indagine filosofica. I metodi educativi paterni ne risvegliarono,
in maniera straordinaria, anche l'immaginazione: divenne maestro nell'arte
di evocare scene e scenari e imparò nello stesso tempo ad abituarsi
alla solitudine e alle meditazioni nella precoce consapevolezza di essere
l'"eccezione". Furono ancora quei metodi a formare il giovane al
rispetto assoluto del dovere e ad avviarlo ad un cristianesimo duro e cupo,
in cui il peccato assumeva un aspetto opprimente e il dovere una forma drammatica.
Ecco perché Kierkegaard ha potuto scrivere nel
Diario che il padre gli aveva riempito l'anima
di angoscia nei confronti del cristianesimo. Egli confessa che fu per questa
educazione "troppo ideale" e "troppo severa"
[8] che non ebbe mai la gioia di essere bambino e di
essere stato infelice fin dalla nascita.
Il padre, trasferendo nel figlio la propria malinconia,
gli si era rivelato sotto l'incubo di una disperazione silenziosa
[9] : Søren risulterà tormentato dall'ambivalente
impressione della vita pia e austera del genitore e del retroscena di cui
intravedeva l'orrore a causa di alcune parole sfuggite, senza avere il coraggio
di andare più a fondo [10] . Ma quello che nell'infanzia era un vago presentimento
di sofferenza, divenne l'orientamento di tutta la vita quando nella prima
gioventù accadde il "… gran terremoto. Il terribile sconquasso
che d'improvviso m'impose un nuovo principio d'interpretazione infallibile
di tutti i fenomeni. …" [11] cioè il sospetto che su suo padre gravasse
la maledizione di Dio e per castigo divino la famiglia dovesse scomparire
per sempre. In un testo scritto l'11 agosto 1838, a tre giorni dalla sua
morte, Kierkegaard ne consacra il ricordo leggendone la scomparsa come l'ultimo
sacrificio affinché si potesse fare del figlio ancora qualcosa. La
conseguente devozione al padre lo farà reus
voti e per questo, come egli dichiara nel 1844,
sosterrà l'esame di teologia (nel 1840) che il vecchio aveva tanto
desiderato, scriverà la tesi Sul concetto
di ironia in riferimento costante a Socrate (1841)
e porterà rapidamente a termine Enten-Eller
(1843) [12] .
Nel 1830, terminati gli studi secondari, infatti,
Kierkegaard si era iscritto all'Università per conseguire il grado
di
Magister Artium ,
un cammino che gli sarebbe costato un decennio di crisi e alternative, compresa
la delusione del vecchio padre che moriva senza vederlo arrivato alla meta
accademica.
 L'influenza di Hegel si faceva allora particolarmente
sentire ed il razionalismo pareva imporsi come la forma perfetta della speculazione.
Kierkegaard non ebbe difficoltà ad entrare nel gioco sottile della
dialettica hegeliana. Era ben lungi tuttavia dall'abbandonarsi alla corrente
idealista che andava affermandosi dovunque e nei confronti della quale si
rafforzava invece la sua opposizione, in nome di un sentimento potente di
quella che egli chiamava la realtà esistenziale, dalla quale l'idealismo
aveva la pretesa di far astrazione
L'influenza di Hegel si faceva allora particolarmente
sentire ed il razionalismo pareva imporsi come la forma perfetta della speculazione.
Kierkegaard non ebbe difficoltà ad entrare nel gioco sottile della
dialettica hegeliana. Era ben lungi tuttavia dall'abbandonarsi alla corrente
idealista che andava affermandosi dovunque e nei confronti della quale si
rafforzava invece la sua opposizione, in nome di un sentimento potente di
quella che egli chiamava la realtà esistenziale, dalla quale l'idealismo
aveva la pretesa di far astrazione
[13] . Kierkegaard non mancò di sottolineare il
lato comico del pensatore "oggettivo ed astratto", dell'idealista
di tipo hegeliano, e più volte affidò ai suoi scritti allusioni
polemiche alla filosofia moderna tacciata di risolversi in uno sterile sistema
e di considerarsi superiore alla religione e alla fede. Dopo i primi cenni
generici e indiretti il tono diventò, con rapida progressione, deciso:
"La filosofia e il Cristianesimo non si lasciano mai conciliare"
[14] e si fece chiara la denuncia che accomunava tutti
quelli che si rendevano responsabili di diluire i contenuti dogmatici del
cristianesimo [15] . Di poco successiva fu una messa a punto più
completa e preoccupata delle sorti di quest'ultimo, in un contesto di denuncia
di un progresso filosofico oltre Hegel, di un entusiasmo spirituale incontrollato
che poteva portare alla bancarotta generale, di una politica che metteva
in pratica i principi hegeliani con risultati ridicoli e deleteri: "…
Ed ora il Cristianesimo, come non è stato trattato? Io condivido del
tutto la sua disapprovazione, che ogni concetto cristiano è stato
così volatilizzato, così completamente dissolto in una tale
nebbia ch'è impossibile poterlo riconoscere. …"
[16] .
Se, soprattutto all'inizio, la conoscenza kierkegaardiana
di Hegel fu mediata da interpreti e commentatori, a mano a mano che seguì
l'abbondante letteratura della teologia speculativa, egli prese anche conoscenza
diretta delle opere del filosofo tedesco maturando sempre più chiaramente
l'opposizione a quest'ultimo data la diversa impostazione problematica del
suo pensiero. Il profondo interesse per la teologia speculativa spiega una
certa dipendenza terminologica e concettuale da Hegel, senza tuttavia alcun
motivo di pensare che Kierkegaard sia mai stato hegeliano, o che la sua filosofia
si regga o cada con quella di Hegel, o che questa ne sia il motivo ispiratore
[17] . Altre motivazioni, allora più urgenti, lo
animavano: il problema religioso della salvezza concretizzato nelle figure
bibliche di Abramo e Giobbe (attorno alle quali saranno costruiti
Timore e tremore e La
ripresa ), l'onnipotenza di Dio e la libertà
dell'uomo, il peccato e la grazia, la Redenzione, la vita cristiana. I riferimenti
ad Hegel erano costanti, ma senza mai proporsi una trattazione sistematica,
tanto Kierkegaard era convinto dell'errata premessa antropologica del sistema
che approdava quindi ad una teologia illusoria. Totalmente diversi anche
l'impostazione, il metodo [18] e lo scopo: erano avulse dall'hegelismo, infatti,
la convinzione kierkegaardiana della validità del sistema limitatamente
all'ordine logico e non in quello dell'esistenza individuale; l'inconciliabilità
tra mediazione filosofica e paradosso della fede; la costante preoccupazione
non di sapere che cos'è il cristianesimo, ma di diventare cristiano;
la persuasione che "solo la verità che edifica è verità
per te", mentre la Storia nulla può aggiungere o togliere all'assoluta
preminenza dell'individuo [19] .
Søren sentì presto l'esigenza di
salvaguardare una personalità di cui avvertiva l'originalità
e la ricchezza; intorno al diciottesimo anno le sue idee sul mondo e sulla
vita andavano modificandosi e lo portavano ad allontanarsi dal padre. Ecco
perché, indirizzato agli studi teologici che avrebbero dovuto avviarlo
al ministero pastorale, non vi si dedicò che distrattamente e saltuariamente
in quanto era ancora incerto sulla carriera da intraprendere e tutto teso
a "…trovare una verità che sia una verità «per me»,
di trovare «l'idea per la quale io voglio vivere e morire». …"
[20] .
Questi conflitti coincidevano con un crescente
distacco dal cristianesimo (come è possibile rilevare da alcuni brani
del
Diario ), tuttavia
cresceva contemporaneamente una concezione che doveva infine imporsi al suo
pensiero per diventare il tema centrale della sua opera; il cristianesimo,
egli scriveva nello stesso periodo, è "…una cura radicale per
la quale ci si schermisce in tutti i modi…"
[21] . Si dedicò per qualche tempo alla vita di
società, di frivolezze estetiche, di apparente disordine. Eppure,
dopo i banchetti durante i quali si imponeva per lo spirito brillante, rincasava
disperato nel più profondo dell'anima, come egli narra
[22] ricordando questo periodo della giovinezza che definisce
"il cammino della perdizione" [23] . Il superamento di questa crisi sembra abbia il suo
inizio precisamente con la morte del padre; il suo progresso si alimentò
delle esperienze successive e dei risultati avuti "alla scuola della
Provvidenza".
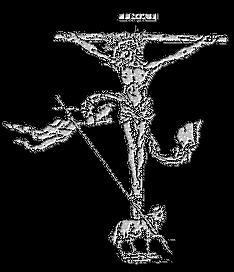 Il tormento però della sua pena più
intima fu quel "pungolo", quella freccia di dolore confitta nelle
sue carni che lo ha segregato fin dalla prima infanzia
Il tormento però della sua pena più
intima fu quel "pungolo", quella freccia di dolore confitta nelle
sue carni che lo ha segregato fin dalla prima infanzia
[24] e il cui segreto egli ha voluto portare con sé
nella tomba: "Dopo la mia morte, non si troverà nelle mie carte
(e questa è la mia consolazione) una sola spiegazione di ciò
che in verità ha riempito la mia vita. Non si troverà nei recessi
della mia anima quel testo che spiega tutto e spesso, di ciò che il
mondo tiene per bagattelle, fa degli avvenimenti di enorme importanza per
me e che anch'io considero futili appena tolgo quella nota segreta che ne
è la chiave." [25] . All'infelicità costitutiva del suo essere
profondo, alla sua "croce particolare" Kierkegaard accennerà
più volte, definendola una "spina nella carne", con l'estrema
circospezione che è imposta da ciò che vi è di sacro
nell'intimità di una realtà conferita da Dio, o comunque permessa
nei suoi disegni [26] . Causa di pene orrende essa gli ha impedito di "diventare
come gli altri uomini", ha inibito il suo realizzarsi nell'ideale etico,
la conclusione del suo fidanzamento con Regina e perfino il suo accesso senza
scrupoli alla carriera pastorale.
Alla sofferenza del pungolo andava congiunta
una profonda malinconia che il vecchio padre gli scaricò addosso quando
era ancora bambino e che lo spinse a condurre una vita di "puro spirito"
aggrappandosi unicamente "all'aspetto intellettuale dell'uomo"
[27] .
In questo contesto assunsero il loro significato
altri due importanti rapporti che si inserirono nella relazione di cui fu
intrisa l'intera sua esistenza: quella con il suo originario padre e autentico
maestro, Dio.
 Il primo fu quello con Regina Olsen che Søren
incontrò nel 1837 e che lasciò dopo poco più di un anno
di fidanzamento nel 1841
Il primo fu quello con Regina Olsen che Søren
incontrò nel 1837 e che lasciò dopo poco più di un anno
di fidanzamento nel 1841
[28] . Tuttavia per lei, ora trasfigurata nei contorni
di un'immagine deliziosa, figura dell'amore consapevole solo di sé,
ora rimproverata come emblema della leggerezza femminile, egli continuò
a serbare un affetto forse ancora più intenso e ideale dopo la rottura,
tanto da indurlo a progettare (negli ultimi anni) una forma di legame spirituale
con colei dalla quale non si era mai staccato nel suo intimo. Comunque siano
state strane e talvolta contraddittorie le vicende del suo fidanzamento con
la giovane –che Kierkegaard non aveva mai seriamente pensato di condurre
al matrimonio [29] – è certo che essa ha dato a tutta la
sua opera di scrittore il significato di un'offerta: "…La mia esistenza
esalterà la sua vita in modo assoluto. La mia carriera di scrittore
potrà anche essere considerata come un monumento a sua lode e gloria.
Io la prendo con me nella storia. …" [30] . Per Regina egli scrisse quasi tutta la vistosa produzione
di Discorsi edificanti
che lei lesse con vivo interesse e con la stima che sempre nutrì
per lo scrittore. La sua figura traspare anche in
Timore e tremore e La
ripresa (ambedue del 1843), nonché nel
Diario del seduttore
e, secondo le sue dimensioni reali-ideali, nell'opera autobiografica degli
Stadi sul cammino della vita
(1845) [31] . In questo punto il Diario
è documento dell'inquietudine di una coscienza che non riusciva a
porre alcuna relazione direttamente nella realtà, ma le trasfigurava
anzitutto nella trascendenza. Regina non era per lui perché Dio doveva
avere la precedenza ed egli non poteva concedersi rapporti finiti al finito.
"…È certo, e quanto volentieri non vorrei dirlo, che umanamente
parlando essa ha e deve avere l'unica e prima priorità della mia vita;
ma in senso assoluto è Dio che ha la prima priorità. Il mio
fidanzamento con «lei» e la sua rottura dipendono in fondo dal
mio rapporto a Dio; formano, se così posso dire, divinamente il mio
fidanzamento con Dio. …" [32] .
 Il pensiero di Kierkegaard era dunque ormai centrato sul problema del cristianesimo e si concretizzava nel conclusivo rapporto a Mynster come relazione alla realtà e finitezza nella forma dell'ordine stabilito rappresentato dal capo della Chiesa danese.
Il pensiero di Kierkegaard era dunque ormai centrato sul problema del cristianesimo e si concretizzava nel conclusivo rapporto a Mynster come relazione alla realtà e finitezza nella forma dell'ordine stabilito rappresentato dal capo della Chiesa danese.
Datosi all'attività letteraria per sfuggire
al risucchio della malinconia e realizzare la sua missione di poeta del religioso
[33] , Kierkegaard inciampò nella gazzarra di scherni
del "Corsaren" ("Corsaro"), il giornale umoristico diretto
da M.A. Goldschmidt, ma che aveva la sua anima nell'esteta amorale P.L. Møller.
Per un anno intero Søren, che con la pubblicazione delle opere estetiche
aveva raggiunto l'apice della celebrità, divenne bersaglio di articoli
e caricature che fecero colpo sul pubblico e strapparono alla vittima una
sdegnosa condanna dell'abiezione della stampa e amare considerazioni sull'uomo
comune [34] . In pochi mesi il "Corsaren" fu sbaragliato
e dovette cessare le pubblicazioni dopo neanche un anno di vita; tuttavia
quell'episodio di villania letteraria fece scoprire al filosofo danese le
categorie fondamentali dell'esistenza inautentica: il pubblico, la massa,
il popolo e l'ordine stabilito come Stato e Chiesa.
 In questo frangente conflittuale si evidenziò un ulteriore motivo di inasprimento dei rapporti con il vescovo Mynster che, non soltanto evitò di difenderlo, ma osò mettere sullo stesso piano lui, la "spia della cristianità" che aveva impegnato tutto per smascherare l'equivoco anticristiano della generazione contemporanea,
e il suo persecutore Goldschmidt. Già da tempo, comunque, la stima
ed ammirazione verso colui che era stato il pastore di suo padre avevano
lasciato il posto ad un crescente sospetto, divenuto poi certezza, del tradimento
dell'ideale cristiano. Il
In questo frangente conflittuale si evidenziò un ulteriore motivo di inasprimento dei rapporti con il vescovo Mynster che, non soltanto evitò di difenderlo, ma osò mettere sullo stesso piano lui, la "spia della cristianità" che aveva impegnato tutto per smascherare l'equivoco anticristiano della generazione contemporanea,
e il suo persecutore Goldschmidt. Già da tempo, comunque, la stima
ed ammirazione verso colui che era stato il pastore di suo padre avevano
lasciato il posto ad un crescente sospetto, divenuto poi certezza, del tradimento
dell'ideale cristiano. Il
Diario
si costellò allora di attacchi all'ambigua politica religiosa nutrita
di compromessi condotta dal capo della Chiesa danese a cui Kierkegaard attribuisce
anche la falsificazione del cristianesimo nell'intento di riconciliarlo con
il mondo. Ma la forza della comunicazione diretta, gettata allo sbaraglio
in una violenta polemica contro la cristianità del proprio tempo,
fu raggiunta da Kierkegaard dopo la morte di Mynster (avvenuta il 30 gennaio
1854) quando il suo successore, il teologo hegeliano H. Martensen, nell'elogio
funebre osò proclamarlo "testimonio della verità".
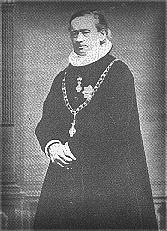 Attese quasi un anno [35] prima di passare all'attacco aperto che coinvolse
non solo il vescovo scomparso, ma l'intera cristianità stabilita.
L'accusa che Kierkegaard sferrò nei fascicoli de "Oejeblikket"
(dal maggio al settembre del 1855), consumandovi le ultime energie del proprio
organismo che infine crollò in un malore che lo condusse alla morte
l'11 novembre del medesimo anno, fu l'esplosione di una crisi maturata nei
rapporti tra lui e Mynster dopo la pubblicazione di
Esercizio del cristianesimo (1850): "…Mynster
pensa probabilmente (e questo è di solito la modernità) che
il Cristianesimo è cultura. Ma questo concetto di cultura è
quanto mai inopportuno e forse perfino diametralmente opposto al Cristianesimo,
quando diventa godimento, raffinatezza, pura cultura umana. …"
[36] . Negli anni che avevano preceduto la polemica egli
aveva precisato con maggior rigore il contrasto netto tra cristianesimo e
cristianità stabilita ed ora, consapevole che "Il Cristianesimo
qui non esiste più; ma perché si possa parlare di riaverlo
bisogna prima spezzare il cuore di un poeta, e questo poeta son io. …"
[37] , poteva tradurre in lotta e sofferenza la verità
cristiana nel tentativo di reintrodurre il cristianesimo nella cristianità.
Attese quasi un anno [35] prima di passare all'attacco aperto che coinvolse
non solo il vescovo scomparso, ma l'intera cristianità stabilita.
L'accusa che Kierkegaard sferrò nei fascicoli de "Oejeblikket"
(dal maggio al settembre del 1855), consumandovi le ultime energie del proprio
organismo che infine crollò in un malore che lo condusse alla morte
l'11 novembre del medesimo anno, fu l'esplosione di una crisi maturata nei
rapporti tra lui e Mynster dopo la pubblicazione di
Esercizio del cristianesimo (1850): "…Mynster
pensa probabilmente (e questo è di solito la modernità) che
il Cristianesimo è cultura. Ma questo concetto di cultura è
quanto mai inopportuno e forse perfino diametralmente opposto al Cristianesimo,
quando diventa godimento, raffinatezza, pura cultura umana. …"
[36] . Negli anni che avevano preceduto la polemica egli
aveva precisato con maggior rigore il contrasto netto tra cristianesimo e
cristianità stabilita ed ora, consapevole che "Il Cristianesimo
qui non esiste più; ma perché si possa parlare di riaverlo
bisogna prima spezzare il cuore di un poeta, e questo poeta son io. …"
[37] , poteva tradurre in lotta e sofferenza la verità
cristiana nel tentativo di reintrodurre il cristianesimo nella cristianità.
Nell'ultimo testo del
Diario , scritto il 25 settembre, Kierkegaard lasciava
trasparire la fine della lotta e il compiersi della sua missione; in "Oejeblikket"
affermava che egli ormai moriva lieto con una gratitudine infinita per la
Provvidenza che gli aveva permesso di soffrire per la propagazione dell'idea
del cristianesimo come "verità sofferente"
[38] . Gli avvenimenti della vita erano stati per lui lezioni
in cui la Provvidenza lo veniva educando al distacco dal finito e la loro
dimensione empirica era sempre stata dominata da quella interiore: un segreto
personale incomunicabile che egli viveva con sé nella sfera dell'eterno,
nel suo rapporto con Dio.
N o t e
 [1]
S.A. KIERKEGAARD,
Diario , IX A 358 (1950),
p. 68 vol. 5.
[1]
S.A. KIERKEGAARD,
Diario , IX A 358 (1950),
p. 68 vol. 5.
 [2]
Cfr. ivi, II A
232 (317), p. 127 vol. 2.
[2]
Cfr. ivi, II A
232 (317), p. 127 vol. 2.
 [3]
Cfr. ivi, VIII
1 A 116 (1406), p. 39 vol. 4.
[3]
Cfr. ivi, VIII
1 A 116 (1406), p. 39 vol. 4.
 [4]
Cfr. ivi, IX A
142 (1828), p. 206 vol. 4; inoltre cfr. ivi, IX A 495 (2043), p. 109 vol.
5; infine cfr. ivi, X 3 A 252
(3062), p. 53 vol. 8.
[4]
Cfr. ivi, IX A
142 (1828), p. 206 vol. 4; inoltre cfr. ivi, IX A 495 (2043), p. 109 vol.
5; infine cfr. ivi, X 3 A 252
(3062), p. 53 vol. 8.
 [5]
Il
Diario di Kierkegaard occupa quasi cinquemila
pagine dei venti volumi in cui è stata raccolta, a Copenaghen, l'edizione
postuma delle sue Carte
. È un'opera iniziata nel 1834, quando il filosofo danese era poco
più che ventenne, e condotta via via con forma ed intensità
diverse, fino agli ultimi giorni di settembre del 1855, meno di due mesi
prima della sua morte, avvenuta l'11 novembre. C. FABRO ha osservato giustamente
che il Diario rivela
l'animo di Kierkegaard come nessun altro suo scritto.
[5]
Il
Diario di Kierkegaard occupa quasi cinquemila
pagine dei venti volumi in cui è stata raccolta, a Copenaghen, l'edizione
postuma delle sue Carte
. È un'opera iniziata nel 1834, quando il filosofo danese era poco
più che ventenne, e condotta via via con forma ed intensità
diverse, fino agli ultimi giorni di settembre del 1855, meno di due mesi
prima della sua morte, avvenuta l'11 novembre. C. FABRO ha osservato giustamente
che il Diario rivela
l'animo di Kierkegaard come nessun altro suo scritto.
(Cfr. C. FABRO,
Introduzione
al Diario , vol. 1,
Brescia 1980, in particolare cap. II, pp. 12-20 e «Prospetto delle
Carte di Kierkegaard»,
pp. 143-153).
 [6]
KIERKEGAARD,
Diario , III A 73 (701), p. 22 vol. 3. Cfr. anche
ivi, I A 68 (49), p. 30 vol. 2 e ivi, I A 72 (51), p. 34 vol. 2.
[6]
KIERKEGAARD,
Diario , III A 73 (701), p. 22 vol. 3. Cfr. anche
ivi, I A 68 (49), p. 30 vol. 2 e ivi, I A 72 (51), p. 34 vol. 2.
 [7]
Ivi , V A 3 (987), p. 118 vol. 3.
[7]
Ivi , V A 3 (987), p. 118 vol. 3.
 [8]
Cfr. ivi, X
2 A 619 (2918), pp. 161-162 vol. 7.
[8]
Cfr. ivi, X
2 A 619 (2918), pp. 161-162 vol. 7.
 [9]
Cfr. ivi, V A
33 (1010), pp. 125-126 vol. 3. Altra scena autobiografica in S.A. KIERKEGAARD,
Colpevole? Non colpevole?
, in Stadi sul cammino della vita di S.A. Kierkegaard
, a cura di L. KOCH, Milano 1993, pp. 331-332.
[9]
Cfr. ivi, V A
33 (1010), pp. 125-126 vol. 3. Altra scena autobiografica in S.A. KIERKEGAARD,
Colpevole? Non colpevole?
, in Stadi sul cammino della vita di S.A. Kierkegaard
, a cura di L. KOCH, Milano 1993, pp. 331-332.
 [10]
Cfr. KIERKEGAARD,
Diario , V A 108 (1051),
p. 137 vol. 3.
[10]
Cfr. KIERKEGAARD,
Diario , V A 108 (1051),
p. 137 vol. 3.
 [11] 11
Ivi , II A 805 (651), p. 210 vol. 2.
[11] 11
Ivi , II A 805 (651), p. 210 vol. 2.
 [12] Cfr. ivi, IV A 70 (868), p. 72 vol. 3.
[12] Cfr. ivi, IV A 70 (868), p. 72 vol. 3.
 [13]
Nel semestre invernale
1835-1836 Kierkegaard seguì le lezioni di P.M. Møller (1794-1838)
sul De anima aristotelico
ed apprezzò questo pensatore, poeta e filologo. L'amore per i Greci
e Socrate in particolare, unito all'ironia, all'avversione al pensiero sistematico
e alla rivendicazione di una interiorità individuale nei confronti
dei pastori e della Chiesa di Stato, resero caro a Kierkegaard il suo professore
al quale è dedicato affettuosamente Il concetto
dell'angoscia e di cui nella
Postilla sta scritto: "Quando tutto era hegeliano,
lui la pensava in modo completamente diverso".
[13]
Nel semestre invernale
1835-1836 Kierkegaard seguì le lezioni di P.M. Møller (1794-1838)
sul De anima aristotelico
ed apprezzò questo pensatore, poeta e filologo. L'amore per i Greci
e Socrate in particolare, unito all'ironia, all'avversione al pensiero sistematico
e alla rivendicazione di una interiorità individuale nei confronti
dei pastori e della Chiesa di Stato, resero caro a Kierkegaard il suo professore
al quale è dedicato affettuosamente Il concetto
dell'angoscia e di cui nella
Postilla sta scritto: "Quando tutto era hegeliano,
lui la pensava in modo completamente diverso".
 [14]
KIERKEGAARD,
Diario , I A 94 (66), p. 48 vol. 2.
[14]
KIERKEGAARD,
Diario , I A 94 (66), p. 48 vol. 2.
 [15]
Cfr. ivi, I A
273 (158), p. 75 vol. 2.
[15]
Cfr. ivi, I A
273 (158), p. 75 vol. 2.
 [16]
Ivi , I A 328 (180), pp. 80-81 vol. 2.
[16]
Ivi , I A 328 (180), pp. 80-81 vol. 2.
 [17]
Secondo S. SPERA
la filosofia kierkegaardiana si concretizza presto, intorno al 1835, quando
di Hegel Kierkegaard ha una conoscenza indiretta e generica.
(Cfr. S. SPERA,
Introduzione a Kierkegaard , Bari 1992
3 , p. 27).
[17]
Secondo S. SPERA
la filosofia kierkegaardiana si concretizza presto, intorno al 1835, quando
di Hegel Kierkegaard ha una conoscenza indiretta e generica.
(Cfr. S. SPERA,
Introduzione a Kierkegaard , Bari 1992
3 , p. 27).
 [18]
Anche la dialettica
kierkegaardiana assume un carattere peculiare: essa fa riferimento ad una
potenza, nella quale si fonda in trasparenza, che obbliga l'individuo alla
scelta rendendolo consapevole del proprio peccato davanti a Dio; è
una dialettica dell'esistenza.
[18]
Anche la dialettica
kierkegaardiana assume un carattere peculiare: essa fa riferimento ad una
potenza, nella quale si fonda in trasparenza, che obbliga l'individuo alla
scelta rendendolo consapevole del proprio peccato davanti a Dio; è
una dialettica dell'esistenza.
 [19]
Diverso, seppure
accomunato da un conclusivo superamento, il riferimento kierkegaardiano a
Socrate, altra figura di primo piano nella formazione del filosofo danese.
Se da Hegel ereditò lo strumento della dialettica, da Socrate attinse
quello dell'ironia e della maieutica. La filosofia greca rappresentava ai
suoi occhi l'approdo sicuro del realismo contro ogni panlogismo e Socrate
il vertice della saggezza, prima e fuori del cristianesimo. Kierkegaard,
tuttavia, criticava il carattere intellettualistico della morale fondata
da Socrate e trovava insufficiente la sua teologia naturale. Con le
Briciole di filosofia (1844) e la
Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia
(1846) infatti, insieme alla riaffermazione del valore della testimonianza
socratica, ne definisce anche il ruolo propedeutico rispetto alla verità
e alla salvezza del cristianesimo.
[19]
Diverso, seppure
accomunato da un conclusivo superamento, il riferimento kierkegaardiano a
Socrate, altra figura di primo piano nella formazione del filosofo danese.
Se da Hegel ereditò lo strumento della dialettica, da Socrate attinse
quello dell'ironia e della maieutica. La filosofia greca rappresentava ai
suoi occhi l'approdo sicuro del realismo contro ogni panlogismo e Socrate
il vertice della saggezza, prima e fuori del cristianesimo. Kierkegaard,
tuttavia, criticava il carattere intellettualistico della morale fondata
da Socrate e trovava insufficiente la sua teologia naturale. Con le
Briciole di filosofia (1844) e la
Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia
(1846) infatti, insieme alla riaffermazione del valore della testimonianza
socratica, ne definisce anche il ruolo propedeutico rispetto alla verità
e alla salvezza del cristianesimo.
 [20]
KIERKEGAARD,
Diario , I A 75 (55), p. 41 vol. 2.
[20]
KIERKEGAARD,
Diario , I A 75 (55), p. 41 vol. 2.
 [21]
Ivi , I A 99 (71), p. 52 vol. 2.
[21]
Ivi , I A 99 (71), p. 52 vol. 2.
 [22]
Cfr. ivi, I A
161 (104), p. 63 vol. 2.
[22]
Cfr. ivi, I A
161 (104), p. 63 vol. 2.
 [23]
Tutto questo spiega
perché i suoi studi procedevano così a rilento. Il padre di
Søren assisteva a questa vita sregolata che tanto contrastava con
l'esistenza austera dell'ambiente familiare. Nel settembre 1837 giunsero
ad una separazione amichevole; il figlio avrebbe percepito una rendita annua
di 500 risdalleri, somma che gli avrebbe consentito di vivere per proprio
conto e di condurre un'esistenza abbastanza agiata, grazie anche ai proventi
di un lavoro redditizio (nell'inverno del 1837-1838, Kierkegaard fu professore
di latino al liceo di Copenaghen), in attesa di prendere una decisione circa
la propria carriera.
[23]
Tutto questo spiega
perché i suoi studi procedevano così a rilento. Il padre di
Søren assisteva a questa vita sregolata che tanto contrastava con
l'esistenza austera dell'ambiente familiare. Nel settembre 1837 giunsero
ad una separazione amichevole; il figlio avrebbe percepito una rendita annua
di 500 risdalleri, somma che gli avrebbe consentito di vivere per proprio
conto e di condurre un'esistenza abbastanza agiata, grazie anche ai proventi
di un lavoro redditizio (nell'inverno del 1837-1838, Kierkegaard fu professore
di latino al liceo di Copenaghen), in attesa di prendere una decisione circa
la propria carriera.
 [24] Cfr.
ivi, VIII 1 A 185 (1447), pp.
58-59 vol. 4.
[24] Cfr.
ivi, VIII 1 A 185 (1447), pp.
58-59 vol. 4.
 [25] Ivi
, IV A 85 (879), pp. 76-77 vol. 3.
[25] Ivi
, IV A 85 (879), pp. 76-77 vol. 3.
 [26]
Concordo con l'affermazione
di P. PRINI per cui l'accanimento dei biografi nel tentativo di individuare
la natura di questo dolore kierkegaardiano nell'ambito di una patologia fisiologica
o psichica non tiene conto del punto più importante della questione.
Non era infatti la natura del male che poteva costituire una chiave interpretativa
del "segreto" di Kierkegaard, ma piuttosto il suo comportamento
religioso di fronte ad esso, la sua interpretazione teologico-esistenziale
del proprio destino stigmatizzato da quella dolorosa eccezione. Questa "palla
di piombo sulle ali" era segnata per lui da un carattere religioso,
il senso le derivava dall'essere una realtà cristiana. La lettura
teologica del proprio stato straordinario è stata il tormento di tutta
la riflessione autobiografica kierkegaardiana, ma anche la lotta decisiva
per la sua conquista della franchezza cristiana.
[26]
Concordo con l'affermazione
di P. PRINI per cui l'accanimento dei biografi nel tentativo di individuare
la natura di questo dolore kierkegaardiano nell'ambito di una patologia fisiologica
o psichica non tiene conto del punto più importante della questione.
Non era infatti la natura del male che poteva costituire una chiave interpretativa
del "segreto" di Kierkegaard, ma piuttosto il suo comportamento
religioso di fronte ad esso, la sua interpretazione teologico-esistenziale
del proprio destino stigmatizzato da quella dolorosa eccezione. Questa "palla
di piombo sulle ali" era segnata per lui da un carattere religioso,
il senso le derivava dall'essere una realtà cristiana. La lettura
teologica del proprio stato straordinario è stata il tormento di tutta
la riflessione autobiografica kierkegaardiana, ma anche la lotta decisiva
per la sua conquista della franchezza cristiana.
(Cfr. P. PRINI,
Storia dell'esistenzialismo.
Da Kierkegaard a oggi , Roma 1989, in particolare
cap. I, pp. 37-42). Per un'interpretazione ulteriore del fenomeno della "spina
nella carne" rimando a FABRO, Introduzione
al Diario , cit., pp.
29-31.
 [27]
Cfr. KIERKEGAARD,
Diario , II A 806 (652),
p. 211 vol. 2.
[27]
Cfr. KIERKEGAARD,
Diario , II A 806 (652),
p. 211 vol. 2.
 [28]
Il 29 settembre
1841, Kierkegaard ottenne il titolo di Magister
Artium con la tesi Sul
concetto di ironia in riferimento costante a Socrate
; l'11 ottobre ruppe definitivamente il fidanzamento con Regina e pochi giorni
dopo partì per Berlino dove frequentò (dal 15 novembre al 4
febbraio 1842) il corso che Schelling teneva all'Università. All'entusiasmo
iniziale seguì una terribile noia che lo trattenne dal continuare,
come risulta dalle lettere all'amico Boesen e al fratello Pietro.
[28]
Il 29 settembre
1841, Kierkegaard ottenne il titolo di Magister
Artium con la tesi Sul
concetto di ironia in riferimento costante a Socrate
; l'11 ottobre ruppe definitivamente il fidanzamento con Regina e pochi giorni
dopo partì per Berlino dove frequentò (dal 15 novembre al 4
febbraio 1842) il corso che Schelling teneva all'Università. All'entusiasmo
iniziale seguì una terribile noia che lo trattenne dal continuare,
come risulta dalle lettere all'amico Boesen e al fratello Pietro.
A proposito di questi scritti che S. SPERA definisce
"scritti del periodo berlinese" e, più in generale, circa
il rapporto tra Kierkegaard e Schelling si veda S. SPERA,
Il pensiero del giovane Kierkegaard , Padova 1977,
in particolare cap. II, pp. 49-94.
 [29]
Cfr. KIERKEGAARD,
Diario , III A 161 (772),
p. 41 vol. 3 e ivi, III A 166 (777), pp. 42-43 vol. 3.
[29]
Cfr. KIERKEGAARD,
Diario , III A 161 (772),
p. 41 vol. 3 e ivi, III A 166 (777), pp. 42-43 vol. 3.
 [30]
Ivi , X 5
A 150 (3796), p. 69 vol. 10.
[30]
Ivi , X 5
A 150 (3796), p. 69 vol. 10.
 [31]
Cfr. in particolare
KIERKEGAARD, Colpevole? Non colpevole?
, cit.
[31]
Cfr. in particolare
KIERKEGAARD, Colpevole? Non colpevole?
, cit.
 [32]
KIERKEGAARD,
Diario , X 5
A 21 (3722), p. 189 vol. 9.
[32]
KIERKEGAARD,
Diario , X 5
A 21 (3722), p. 189 vol. 9.
 [33]
Cfr. ivi, IX A
213 (1868), pp. 24-25 vol. 5.
[33]
Cfr. ivi, IX A
213 (1868), pp. 24-25 vol. 5.
 [34]
Per un ampliamento
della tematica relativa al rapporto tra Kierkegaard e il giornalismo con
particolare riguardo alla vicenda del "Corsaren" rimando a SPERA,
Il pensiero , cit., cap.
II, pp. 147-175.
[34]
Per un ampliamento
della tematica relativa al rapporto tra Kierkegaard e il giornalismo con
particolare riguardo alla vicenda del "Corsaren" rimando a SPERA,
Il pensiero , cit., cap.
II, pp. 147-175.
 [35]
Kierkegaard nel
primo articolo di protesta contro l'elogio di Martensen a Mynster chiedeva
nel titolo: Era il vescovo Mynster un testimonio
della verità, uno di quei veri testimoni: è mai vero questo?
. L'articolo, scritto nel febbraio 1854, fu pubblicato in "Faedrelandet"
soltanto il 18 dicembre. Dopo la replica di Martensen sul "Berlingske
Tidende", Kierkegaard contrattaccò nuovamente e quando, alla
fine del marzo 1855, si affievolì la polemica diretta sui giornali,
Kierkegaard continuò su "Faedrelandet" l'attacco ormai inarrestabile
alla cristianità stabilita.
[35]
Kierkegaard nel
primo articolo di protesta contro l'elogio di Martensen a Mynster chiedeva
nel titolo: Era il vescovo Mynster un testimonio
della verità, uno di quei veri testimoni: è mai vero questo?
. L'articolo, scritto nel febbraio 1854, fu pubblicato in "Faedrelandet"
soltanto il 18 dicembre. Dopo la replica di Martensen sul "Berlingske
Tidende", Kierkegaard contrattaccò nuovamente e quando, alla
fine del marzo 1855, si affievolì la polemica diretta sui giornali,
Kierkegaard continuò su "Faedrelandet" l'attacco ormai inarrestabile
alla cristianità stabilita.
 [36]
KIERKEGAARD,
Diario , X 3
A 588 (3229), p. 132 vol. 8.
[36]
KIERKEGAARD,
Diario , X 3
A 588 (3229), p. 132 vol. 8.
 [37]
Ivi , X 4
A 586 (3655), p. 142 vol. 9.
[37]
Ivi , X 4
A 586 (3655), p. 142 vol. 9.
 [38]
P. PRINI afferma
che, essendosi Kierkegaard proposto di cercare la verità cristiana
sperimentandola nella propria esistenza, la filosofia che ne risulta vuole
essere una vera e propria teologia sperimentale, e in questo senso è
un'autobiografia teologica. Questa interpretazione mi trova concorde. (Cfr. PRINI, Storia dell'esistenzialismo
, cit., in particolare cap. I, pp. 20-25).
[38]
P. PRINI afferma
che, essendosi Kierkegaard proposto di cercare la verità cristiana
sperimentandola nella propria esistenza, la filosofia che ne risulta vuole
essere una vera e propria teologia sperimentale, e in questo senso è
un'autobiografia teologica. Questa interpretazione mi trova concorde. (Cfr. PRINI, Storia dell'esistenzialismo
, cit., in particolare cap. I, pp. 20-25).
Impaginazione e grafica: Giorgio Ruffa (©2000)
Per una visualizzazione ottimale si consiglia 800x600
|
 |
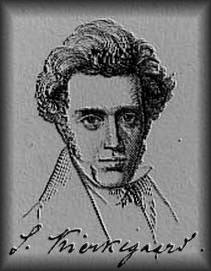 "Come mai può
venire in mente a qualcuno di fare l'elogio di quest'esistenza dove non c'è
che l'alternativa: o
di sopprimere in modo abominevole (crimine peggiore di un aborto) ogni aspirazione
ideale in grande stile e ogni possibilità d'idealità vera,
in ogni modo dimezzarla in maniera rivoltante… per poi gonfiarsi e rimpinzarsi
nella sconcia obesità degli onori e della stima mondani, –
oppure , qualora si voglia l'ideale, ci si deve
preparare a essere, eo ipso
, martiri.
"Come mai può
venire in mente a qualcuno di fare l'elogio di quest'esistenza dove non c'è
che l'alternativa: o
di sopprimere in modo abominevole (crimine peggiore di un aborto) ogni aspirazione
ideale in grande stile e ogni possibilità d'idealità vera,
in ogni modo dimezzarla in maniera rivoltante… per poi gonfiarsi e rimpinzarsi
nella sconcia obesità degli onori e della stima mondani, –
oppure , qualora si voglia l'ideale, ci si deve
preparare a essere, eo ipso
, martiri.
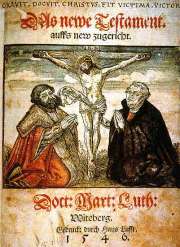 Saldamente ancorato al messaggio del Nuovo Testamento come all'unica cura radicale, Kierkegaard contesterà allora alla cristianità
stabilita gli inganni delle sue false prospettive di benessere terreno che
l'hanno riconciliata con il mondo.
Saldamente ancorato al messaggio del Nuovo Testamento come all'unica cura radicale, Kierkegaard contesterà allora alla cristianità
stabilita gli inganni delle sue false prospettive di benessere terreno che
l'hanno riconciliata con il mondo.
 Il padre esercitò sulla vita morale e
spirituale di Søren, ultimo di sette figli, un'azione potente e durevole.
Kierkegaard nel
Il padre esercitò sulla vita morale e
spirituale di Søren, ultimo di sette figli, un'azione potente e durevole.
Kierkegaard nel  L'influenza di Hegel si faceva allora particolarmente
sentire ed il razionalismo pareva imporsi come la forma perfetta della speculazione.
Kierkegaard non ebbe difficoltà ad entrare nel gioco sottile della
dialettica hegeliana. Era ben lungi tuttavia dall'abbandonarsi alla corrente
idealista che andava affermandosi dovunque e nei confronti della quale si
rafforzava invece la sua opposizione, in nome di un sentimento potente di
quella che egli chiamava la realtà esistenziale, dalla quale l'idealismo
aveva la pretesa di far astrazione
L'influenza di Hegel si faceva allora particolarmente
sentire ed il razionalismo pareva imporsi come la forma perfetta della speculazione.
Kierkegaard non ebbe difficoltà ad entrare nel gioco sottile della
dialettica hegeliana. Era ben lungi tuttavia dall'abbandonarsi alla corrente
idealista che andava affermandosi dovunque e nei confronti della quale si
rafforzava invece la sua opposizione, in nome di un sentimento potente di
quella che egli chiamava la realtà esistenziale, dalla quale l'idealismo
aveva la pretesa di far astrazione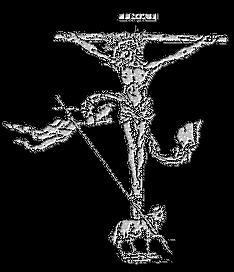 Il tormento però della sua pena più
intima fu quel "pungolo", quella freccia di dolore confitta nelle
sue carni che lo ha segregato fin dalla prima infanzia
Il tormento però della sua pena più
intima fu quel "pungolo", quella freccia di dolore confitta nelle
sue carni che lo ha segregato fin dalla prima infanzia Il primo fu quello con Regina Olsen che Søren
incontrò nel 1837 e che lasciò dopo poco più di un anno
di fidanzamento nel 1841
Il primo fu quello con Regina Olsen che Søren
incontrò nel 1837 e che lasciò dopo poco più di un anno
di fidanzamento nel 1841 Il pensiero di Kierkegaard era dunque ormai centrato sul problema del cristianesimo e si concretizzava nel conclusivo rapporto a Mynster come relazione alla realtà e finitezza nella forma dell'ordine stabilito rappresentato dal capo della Chiesa danese.
Il pensiero di Kierkegaard era dunque ormai centrato sul problema del cristianesimo e si concretizzava nel conclusivo rapporto a Mynster come relazione alla realtà e finitezza nella forma dell'ordine stabilito rappresentato dal capo della Chiesa danese.
 In questo frangente conflittuale si evidenziò un ulteriore motivo di inasprimento dei rapporti con il vescovo Mynster che, non soltanto evitò di difenderlo, ma osò mettere sullo stesso piano lui, la "spia della cristianità" che aveva impegnato tutto per smascherare l'equivoco anticristiano della generazione contemporanea,
e il suo persecutore Goldschmidt. Già da tempo, comunque, la stima
ed ammirazione verso colui che era stato il pastore di suo padre avevano
lasciato il posto ad un crescente sospetto, divenuto poi certezza, del tradimento
dell'ideale cristiano. Il
In questo frangente conflittuale si evidenziò un ulteriore motivo di inasprimento dei rapporti con il vescovo Mynster che, non soltanto evitò di difenderlo, ma osò mettere sullo stesso piano lui, la "spia della cristianità" che aveva impegnato tutto per smascherare l'equivoco anticristiano della generazione contemporanea,
e il suo persecutore Goldschmidt. Già da tempo, comunque, la stima
ed ammirazione verso colui che era stato il pastore di suo padre avevano
lasciato il posto ad un crescente sospetto, divenuto poi certezza, del tradimento
dell'ideale cristiano. Il 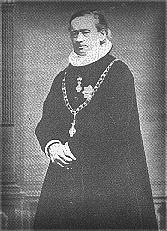 Attese quasi un anno [35] prima di passare all'attacco aperto che coinvolse
non solo il vescovo scomparso, ma l'intera cristianità stabilita.
L'accusa che Kierkegaard sferrò nei fascicoli de "Oejeblikket"
(dal maggio al settembre del 1855), consumandovi le ultime energie del proprio
organismo che infine crollò in un malore che lo condusse alla morte
l'11 novembre del medesimo anno, fu l'esplosione di una crisi maturata nei
rapporti tra lui e Mynster dopo la pubblicazione di
Esercizio del cristianesimo (1850): "…Mynster
pensa probabilmente (e questo è di solito la modernità) che
il Cristianesimo è cultura. Ma questo concetto di cultura è
quanto mai inopportuno e forse perfino diametralmente opposto al Cristianesimo,
quando diventa godimento, raffinatezza, pura cultura umana. …"
[36] . Negli anni che avevano preceduto la polemica egli
aveva precisato con maggior rigore il contrasto netto tra cristianesimo e
cristianità stabilita ed ora, consapevole che "Il Cristianesimo
qui non esiste più; ma perché si possa parlare di riaverlo
bisogna prima spezzare il cuore di un poeta, e questo poeta son io. …"
[37] , poteva tradurre in lotta e sofferenza la verità
cristiana nel tentativo di reintrodurre il cristianesimo nella cristianità.
Attese quasi un anno [35] prima di passare all'attacco aperto che coinvolse
non solo il vescovo scomparso, ma l'intera cristianità stabilita.
L'accusa che Kierkegaard sferrò nei fascicoli de "Oejeblikket"
(dal maggio al settembre del 1855), consumandovi le ultime energie del proprio
organismo che infine crollò in un malore che lo condusse alla morte
l'11 novembre del medesimo anno, fu l'esplosione di una crisi maturata nei
rapporti tra lui e Mynster dopo la pubblicazione di
Esercizio del cristianesimo (1850): "…Mynster
pensa probabilmente (e questo è di solito la modernità) che
il Cristianesimo è cultura. Ma questo concetto di cultura è
quanto mai inopportuno e forse perfino diametralmente opposto al Cristianesimo,
quando diventa godimento, raffinatezza, pura cultura umana. …"
[36] . Negli anni che avevano preceduto la polemica egli
aveva precisato con maggior rigore il contrasto netto tra cristianesimo e
cristianità stabilita ed ora, consapevole che "Il Cristianesimo
qui non esiste più; ma perché si possa parlare di riaverlo
bisogna prima spezzare il cuore di un poeta, e questo poeta son io. …"
[37] , poteva tradurre in lotta e sofferenza la verità
cristiana nel tentativo di reintrodurre il cristianesimo nella cristianità.

