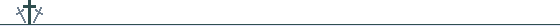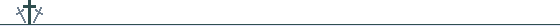

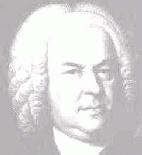
Il carattere oggettivo della musica ha il grande potere di produrre nel soggetto delle
reazioni particolari, che a suo tempo andavano sotto il nome di Affetti, e che solo
quest'arte permette. Ma, parafrasando Hegel, il principio della soggettività diventa
momento della religione medesima. Come sappiamo il protestantesimo si basa appunto su
questo principio. Conseguentemente questo scambio oggetto-soggetto permette una
sublime sintesi, la quale riesce ad avvicinare, disciogliere direbbe Hegel, la coscienza
soggettiva verso il suo principio assoluto. La musica, in altre parole, è uno dei mezzi
forniteci da Dio per glorificare il suo nome e per partecipare attivamente alla bellezza e
all'armonia del creato: infatti sta scritto che ogni vivente dia lode al Signore (Salm. 150,
6).
Una prima descrizione della potenza della musica la possiamo ricavare dal secondo
libro delle Cronache (5, 13-14) dove troviamo scritto: Avvenne che, quando i suonatori e i
cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle
trombe, dei cembali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono,
perché la sua grazia dura sempre, allora il tempio si riempì di una nube, cioè della gloria
del Signore. I sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube,
perché la gloria del Signore aveva riempito il tempio di Dio.
Dal passo appena letto appare un luogo tipico nelle Scritture: il suono è spesso
collegato alla potenza di Dio. Un simbolo fra tutti, che non necessita commenti, è il suono
marziale della Tromba. I passi in cui questo strumento appare sono i seguenti: Esodo
19:13 ; 19:16; 19:19; 20:18; Levitico 25:9; Numeri 10:4; Giosuè 6:5; 6:20; Giudici 3:27;
6:34; 7:16; 7:18; 1 Samuele 13:3; 2 Samuele 2:28; 6:15; 15:10; 18:16; 20:1; 20:22; 1 Re
1:34; 1:39; 1:41; Neemia 4:18; 4:20; Giobbe 39:24; Salmi 47:5; 81:3; 150:3; Isaia 18:3;
27:13; 58:1; Geremia 4:5; 4:19; 4:21; 6:1; 6:17; 42:14; 51:27; Ezechiele 7:14; 33:3-6;
Osea 5:8; 8:1; Gioele 2:1; 2:15; Amos 2:2; 3:6; Sofonia 1:16; Zaccaria 9:14; Matteo 6:2;
24:31; 1 Corinti 14:8; 15:52; Ebrei 12:19; Apocalisse 1:10; 4:1; 8:13; 9:14.
I passi che invece indicano il canto in onore di Dio sono moltissimi, basti pensare al
Salterio. La lista che segue non pretende di essere completa, ma spero possa essere utile a
chi è interessato all'argomento: Esodo 15:1; 15:21; 32:18; Numeri 21:17; Giudici 5:3; 1
Samuele 21:11; 2 Samuele 22:50; 1 Cronache 16:9; 16:23; 16:33; 2 Chronicles 20:22;
23:13; 29:30; Giobbe 29:13; Salmi 7:17; 9:2; 9:11; 13:6; 18:49;21:13; 27:6; 30:4; 30:12;
33:2-3; 47:6-7; 51:14; 57:7; 57:9; 59:16-17; 61:8; 65:13; 66:2; 66:4; 67:4; 68:4; 68:32;
71:22-23; 75:9; 81:1; 89:1; 92:1; 95:1; 96:1,2; 98:1,4,5; 101:1; 104:12, 33; 105:2; 108:1,
3; 135:3; 137:3,4; 138:1,5; 144:9; 145:7; 146:2; 147:1,7; 149:1,3,5; Proverbi 29:6; Isaia
5:1; 12:5; 24:14; 26:19; 27:2; 35:6; 38:20; 42:10; 42:11; 44:23; 49:13; 52:8; 52:9; 65:14;
20:13; Geremia 31:7,12; 51:48; Ezechiele 27:25; Osea 2:15; Sofonia 3:14; Zaccaria 2:10;
Romani 15:9; 1 Corinti 14:15; Ebrei 2:12; Giacomo 5:13; Apocalisse 15:3.
Qualcuno potrà notare che in Daniele 3:10,15 la musica diventa uno strumento di
idolatria. Il pericolo di seduzione della musica era stato avvertito da Agostino, Lutero,
Calvino ed altri. Ognuno reagì in modo diverso: celebre l'iniziale avversione all'organo di
Lutero, la proibizione della musica di Calvino etc... Tutti, peró, dovettero arrendersi
all'evidenza: come tutti i mezzi della creazione la musica non era pericolosa in se', bensì
nel modo in cui veniva usata. Lutero affermava: I giovani abbiano di che sostituire i loro
canti licenziosi e possano in loro vece imparare canti educativi e accostarsi al bene come a
loro conviene. Il vero problema, come già detto, non era la musica in quanto tale, ma
essendo quest'ultima dono divino essa doveva accompagnarsi a dei testi consoni a questa
prerogativa. Quindi musica ad Soli Deo Gloria.
Nel campo della riforma Martin Lutero diede, successivamente, un'enorme importanza
dottrinale alla musica come forma di espressione religiosa. Per il riformatore, come per
Agostino di Tagaste, il canto era una preghiera due volte detta. La parola cantata
permetteva alla riunione dei fedeli, che ai suoi tempi erano per la maggioranza incolti, di
imparare facilmente i temi della fede cristiana, dal momento che i testi dei Lieder erano in
tedesco. Volendo fare un paragone essi avevano la stessa funzione, ma con fini e concetti
teologici diversi, dei mosaici e dei dipinti all'interno delle chiese cattoliche. Inoltre la
musica, in quanto tale, permetteva una profonda Koiné tra i fedeli.
Vediamo ora che cosa dice il riformatore sull'importanza della musica: La musica è un
po' come una disciplina che rende gli uomini più pazienti e più dolci, più modesti e più
ragionevoli. Chi la disprezza, come fanno tutti i fanatici, non può concordare su questo
punto. Essa è un dono di Dio e non degli uomini; essa scaccia il maligno e rende felici.
Grazie alla musica si dimentica la collera e tutti i vizi. Perciò, e sono pienamente convinto
di ciò che dico e non ho alcun timore di dirlo, dal punto di vista teologico nessun'arte può
stare alla pari della musica [...] È assolutamente necessario conservare la musica nella
scuola. [...] Bisogna abituare i giovani a quest'arte. [...] Il canto è l'arte più bella e il
migliore esercizio. [...] Chi sa cantare non si abbandona ne' ai dispiaceri ne' alla tristezza;
è allegro e scaccia gli affanni con le canzoni (Lettera del 1530 indirizzata al musicista
Senfl).
Ma ancor prima di Lutero, che come è noto era agostiniano, il canto veniva così
lodato da Agostino: Sento che le anime nostre assurgono nella fiamma della pietà con un
ardore ed una devozione maggiore per le sante parole, quando sono accompagnate dal
canto, e tutti i diversi sentimenti del nostro spirito trovano nel canto una loro propria
espressione che li risveglia (Confessioni, lib. X, c. 33).
Lutero realizzò il suo progetto, Soli Deo Gloria, attraverso il Corale: una semplice ma
espressiva forma di canto. Il nome “Corale” è un aggettivo sostantivato che deriva
dall'espressione «cantus choralis», ovvero una melodia, normalmente omofona, eseguita,
alle origini, a più voci all'unisono senza accompagnamento.
Vediamo, a titolo di cronaca, di tracciare, brevemente, le origini ed il significato del
corale nella liturgia protestante. I corali, differentemente dai canti cattolici, non erano
scritti in latino, questo per favorire la massima partecipazione dei fedeli. Lodovico II (Imperatore d'Occidente 855-875) lamentava la scarsa partecipazione dell'assemblea durante la messa; nei "Capitula Ecclesiastica" (anno 856) affermò: Tertium intimandum, ut ad salutationes sacerdotales congrue responsiones discantur, ubi non solum clerici et Deo dicatae sacerdoti responsionem offerant, sed omnis plebes devota consona voce respondere debet.
Dal punto di vista musicale questo canto liturgico era inizialmente monofonico,
sebbene eseguito da più voci: al massimo si contrapponeva una vox organalis, in
moto parallelo, distante una 4a o una 5a. Esso deriva dalla liturgia "secundum uso
romanum" cantato nel modo melodizzante ovvero in Concentus, il contrario dell'Accentus
che era il modo declamatorio, vicino al recitativo. Il corale si sviluppò, seguendo il
progresso della tecnica musicale, in svariate forme: monofonico, polifonico di tipo
mottettistico e polifonico di tipo armonizzato. Molti canti in lingua volgare, da quelli dei
Minnesänger a quelli penitenziali ed anche quelli militari, divennero, poi, corali. Le origini
sono quindi di molto anteriori alla riforma. In forma compiuta troviamo dei Lied a partire
dal XI secolo. Il fiorente sviluppo di questi canti religiosi, nel periodo in questione, è
testimoniato, in modo indiretto, dai vari divieti ecclesiastici emanati dai concili di Basilea
(1435) e Eichstatt (1446), dai sinodi di Praga (1406) e Schwerin (1492). Difatti,
formalmente, l'unico canto liturgico consentito era quello latino-gregoriano.
Lutero quindi, senza nulla, o quasi, inventare, nell'organizzare la nuova liturgia,
poteva basarsi su di una tradizione gia' consolidata nell'ambiente popolare; era forse la
strada più diretta visto, poi, che non era neppure pensabile che il popolo fosse in grado
d'intonare il difficile canto gregoriano. Parlare ora delle elaborazioni, da parte di Lutero o
della chiesa luterana in generale, di corali e di Gesangbücher esula dalle intenzioni di
questo articolo. Aggiungiamo solo che la forma corale fu portata al suo massimo
splendore da uno dei più grandi artisti di tutti i tempi: Johann Sebastian Bach (1685-
1750).
Per concludere vorremmo riassumere, anche se assolutamente non appartenente al
nostro contesto, il pensiero di Tommaso d'Aquino sull'argomento, solo perché segue da
vicino Agostino. L'aquinate in una quaestio della Summa Theologica (IIa IIae, q.91,
a.2 ) si chiede se per innalzare lodi a Dio sia necessario il canto. La risposta, partendo dal
presupposto che il fine dell'uomo è amare Dio, dice che è giusto servirci di tutto ciò che ci
possa aiutare a rinforzare questo amore. Il canto, ovvero la musica, è lo strumento più
adatto in quanto risulta essere, nella sfera del sensibile, la creazione divina che più tende
allo spirituale; inoltre tutto ciò che è creato da Dio è disposto per la sua gloria, in virtù del
fatto che tutto è creato non per necessita' ma per se stesso propter semetipsum. E
aggiungerei, come chiusura, il Salmo 150: Lodate Iddio nel suo santuario,/ lodatelo nella
distesa della sua gloria./ Lodatelo per i suoi prodigi,/ lodatelo secondo la sua somma
grandezza./ Lodatelo col suon della tromba,/ lodatelo col saltero e con la cetra;/ lodatelo
col tamburo e col flauto,/ lodatelo coll'arpicodo e con l'organo./ Lodatelo con cembali
sonanti,/ lodatelo con cembali squillanti;/ ogni cosa che ha fiato lodi il Signore./
Alleluja.